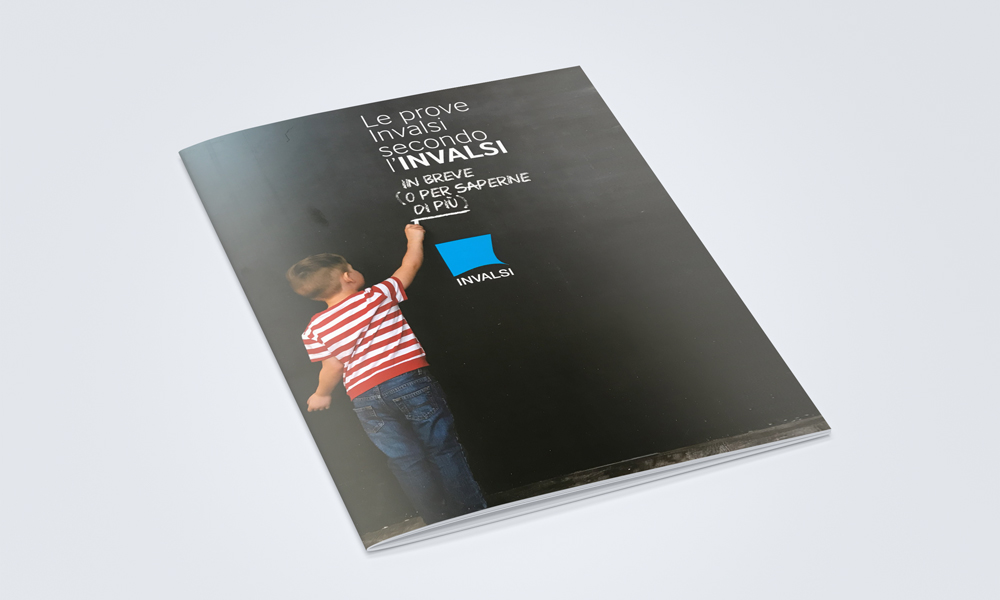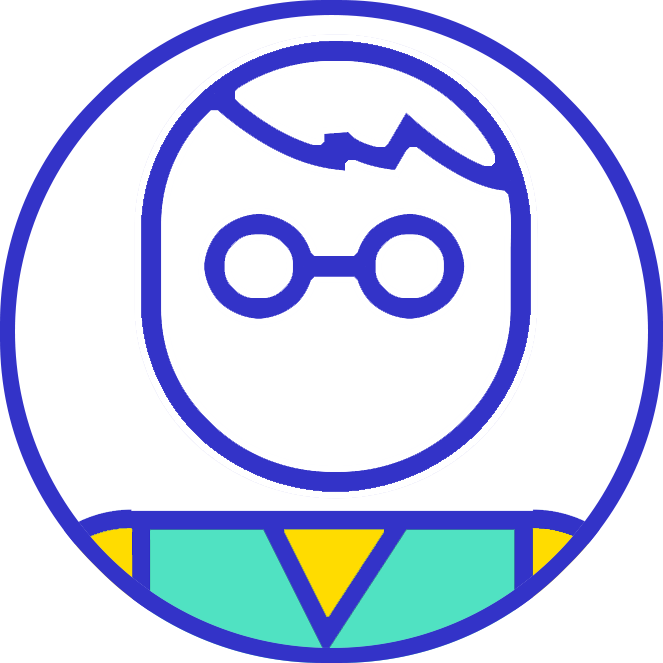Nonostante i ragazzi vi passino più tempo che nella maggior parte degli altri paesi, la scuola non riesce ad attenuare le disuguaglianze sociali di partenza. Secondo le indagini internazionali, una ragione importante è che i nostri ragazzi risultano in media meno bravi degli altri nell’utilizzare quello che hanno imparato.
Come se una parte della scuola italiana facesse trenta, ma non riuscisse a fare trentuno.
Prove uguali per tutti servono a capire dove c’è qualcosa da migliorare.
Non a caso si fanno in quasi tutti i paesi europei. Perché la scuola pubblica non può permettersi di avere classi di serie A e di serie B.
Secondo l’articolo 3 della Costituzione:
“È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.”
Una parte cruciale di questo compito è affidata alla scuola, che aiuta a formare i ragazzi come persone, cittadini e lavoratori, e che è stata una protagonista della trasformazione epocale vissuta dal Paese negli ultimi decenni.
Una serie di segnali ci dicono però che una parte della scuola italiana non riesce oggi a svolgere fino in fondo questo ruolo.
Nonostante i ragazzi passino tanto tempo in aula, la scuola non riesce ad attenuare le loro disuguaglianze di partenza.
Quindici ragazzi su cento abbandonano prima di aver conseguito il titolo di studio, ma diventano trenta se calcoliamo la differenza fra iscritti al primo ciclo e diplomati alla maturità.
La dispersione riguarda i figli di genitori che hanno al massimo il diploma di terza media in misura quattro volte più alta rispetto ai figli di genitori laureati. Dati analoghi si ottengono confrontando il profilo professionale dei genitori.
Anche i risultati scolastici di chi continua a studiare sono tanto più alti, quanto migliori sono le condizioni socio-economiche della famiglia di provenienza. Il risultato è che più di un giovane su cinque fra i 15 e i 24 anni non studia e non lavora.
Un altro segnale è la crescente difficoltà con la quale si incontrano domanda e offerta di lavoro. A un alto tasso di disoccupazione giovanile si contrappone in molte aree la difficoltà per le imprese nel reperire personale qualificato, a tutti i livelli.
L’Italia è diventata uno dei paesi in cui il titolo di studio conseguito è meno correlato con la possibilità di trovare un lavoro e con il livello professionale ed economico raggiunto.
Specchio di tutto questo è la debolezza culturale del paese, attestata da diverse indagini nazionali e internazionali così come dai dati sui consumi culturali: appena 30 italiani su 100, fra i 16 e i 65 anni, possiedono i livelli sufficienti di literacy e numeracy necessari per interagire in modo efficace in una società e un’economia avanzate.
È chiaro che su questi dati influiscono anche fattori che con la scuola non hanno nulla a che fare, ma proprio le indagini internazionali – ad esempio quella OCSE-PISA – ci dicono che non tutti i nostri ragazzi sono molto bravi nel saper utilizzare quello che hanno imparato, ovvero in quelle competenze che più servono oggi.
Questo d’altra parte conferma un’osservazione che è stata fatta spesso, e cioè che la formazione tipica storicamente offerta nel nostro paese è fondata più su un bagaglio di conoscenze, piuttosto che di competenze. Di sapere, più che di saper fare.
In questi anni la scuola non è rimasta ferma, ma la sua capacità di rispondere a queste sfide è molto diversa fra nord e sud del Paese come all’interno della medesima scuola.
L’INVALSI è nato proprio per misurare gli esiti di apprendimento di alcune competenze chiave, quindi per verificare e stimolare il necessario rinnovamento della scuola italiana.
Questa misurazione può essere fatta solo attraverso prove oggettive uguali per tutti.
Solo se tutti vengono misurati con lo stesso metro, i dati ottenuti permettono di leggere il fenomeno con la massima risoluzione, sono comparabili nello spazio e nel tempo, e sono veramente utili.
Non a caso la stessa soluzione – allo stesso problema – l’hanno adottata quasi tutti i paesi europei, che hanno introdotto sistemi di valutazione e autovalutazione basati su prove standardizzate, gestiti da enti analoghi all’lNVALSI.
Se l’istruzione è fondamentale per garantire a tutti uguali possibilità, la scuola pubblica ha il dovere di non lasciare che esistano territori, o scuole, o classi di serie A e di serie B.
Delle Prove INVALSI, invece, una scuola privatizzata non avrebbe alcun bisogno.